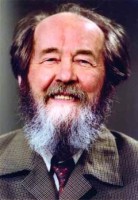L’articolo a firma di Carlo De Risio, pubblicato sul quotidiano Il Tempo del 23 ottobre 1998, riporta interessanti dati sulle condizioni delle Casse degli Stati italiani, prima della conquista piemontese. La fonte alla quale De Risio fa riferimento è uno scritto poco noto dell’economista Francesco Saverio Nitti (Melfi, 1868 – Roma, 1953), esponente del Partito Radicale Storico che fu più volte ministro e Presidente del Consiglio del Regno d’Italia nel 1919. Una fonte, dunque, che difficilmente potrebbe essere definita “filoborbonica”.
Guerra di conquista e di rapina
Uno dei momenti centrali del “Gattopardo” – il romanzo di Tommasi di Lampedusa – è il colloquio tra il principe di Salinomo un seggio nel Senato di Torino. Il principe, rappresentante dell’“ancia e un funzionario piemontese, inviato in Sicilia per offrire al nobiluen régime” borbonico decaduto, declina l’offerta, mentre il funzionario fa intravedere i futuri vantaggi della moderna ed efficiente amministrazione piemontese – asse portante dell’Italia appena unificata – per il riscatto materiale e morale del Mezzogiorno.
In realtà, subito dopo il 1860, il Mezzogiorno conobbe soltanto una vera e propria campagna militare, – con non pochi eccessi – per combattere il brigantaggio, diretto in molte zone da ex ufficiali borbonici e sostenuto dallo Stato Pontificio (Pio IX aveva reagito alla nascita del regno d’Italia pronunciando una minacciosa profezia, convinto che quanto era avvenuto tra il 1859 e il 1860 sarebbe stato «tutto disfatto daccapo a suo tempo»).
In quel lasso di tempo, nelle esauste casse di Vittorio Emanuele II, si riversarono non soltanto i milioni (dell’epoca) degli Stati del centro-nord, ma le ben più pingui risorse finanziarie di Napoli. A quanto ammontavano queste risorse? Dove e come furono impiegate? È soltanto un luogo comune che avvenne una vera e propria “rapina”, trasferendo al Nord quanto c’era in cassa a Napoli, per cui il problema del mezzogiorno si pose da allora, per diventare il cruccio e la croce di tutti i regimi ed i governi succedutisi in Italia da centoquarant’anni a questa parte?
In un dimenticato testo Francesco Saverio Nitti, lo statista di Melfi – a lungo titolare di cattedra di Scienza delle Finanze all’Università di Napoli – scrive: «Le monete degli Stati italiani al momento dell’annessione ammontavano a 668,4 milioni» (Edizioni Pierro, 1909). Si tratta di un dato poco noto, che raramente viene citato e che è invece la chiave di comprensione delle disfunzioni “storiche” del nostro Paese.
Di questi 668,4 milioni, 641,4 si trovavano negli Stati annessi nel decennio 1860-1870, fino alla presa di Roma.
Ancora: più di due terzi del totale – 443,2 milioni – erano custoditi nelle casse del Regno delle Due Sicilie.
Consistenti anche le riserve dello Stato Pontificio, con 90,6 milioni distribuiti tra Roma, l’Umbria, le Marche e la Romagna.
Grazie alla oculata amministrazione dei Lorena – dinastia molto liberale – a Firenze, capitale del Granducato di Toscana, si trovavano altri 85,2 milioni.
Modesto l’apporto dei Ducati di Modena, Parma e Piacenza, con 1,6 milioni, mentre le annessioni della Lombardia e di Venezia assicurarono rispettivamente 8,1 e 12,7 milioni.
All’inizio di questa “raccolta”, nel 1860 – l’anno della Spedizione dei Mille e della campagna di Vittorio Emanuele II nell’Italia centrale e meridionale – nelle casse di Torino c’erano appena 27 milioni.
Va doverosamente ricordato che la “povertà” del Regno di Sardegna era dovuta al prolungato sforzo bellico e soprattutto agli impegni assunti con Napoleone III, per indurlo a partecipare nel 1859 alla guerra contro l’Austria
Cavour aveva fatto votare dal Parlamento e dal Senato un prestito di guerra di 50 milioni, ma i banchieri europei si erano rifiutati di sostenerlo, costringendo il governo di Torino a lanciare, all’interno, un prestito di oltre 30 milioni, rapidamente sottoscritto. Ma questo era il meno.
Napoleone III, oltre a ottenere la Savoia e Nizza, ad accarezzare disegni dinastici a favore del cugino Girolamo Napoleone, detto “Plon Plon” (era prevista una Confederazione di Stati Italiani sotto la presidenza onoraria del Papa), ed a spingere il proprio “appetito” fino ad aspirare alla Liguria e alla Sardegna, pretese il pagamento di 60 milioni di lire, a titolo di risarcimento per le spese di guerra. La partecipazione francese alla campagna del 1859 fu dunque pagata a caro prezzo e le finanze di Torino ne uscirono stremate.
Questo il quadro nella sua interezza. Ora, al di là dei luoghi comuni e di una oleografia di comodo del Risorgimento, è fuori discussione che l’Italia unitaria trasse linfa vitale e forza dai 443 milioni trovati nelle casse di Napoli. Non è molto esagerata l’immagine popolare di un Vittorio Emanuele II che se ne tornò in Piemonte con denaro sonante, in oro.
Decisiva, allora e in seguito, l’argomentazione secondo la quale la gracile Italia nata dall’unificazione di sette Stati non poteva che privilegiare il Nord, per la sua stessa collocazione geografica, a contatto con Paesi europei più progrediti e sviluppati: di qui la nascita di zone industriali, di infrastrutture, di una adeguata rete ferroviaria.
Ma è un fatto che i 443 milioni lasciati da Francesco II di Borbone non rimasero al Sud. Il problema del Mezzogiorno, ab ovo, si pose con quella scelta.
Che poi, dal secondo dopoguerra ad oggi, le varie “Casse” abbiano vanamente destinato al Sud un profluvio di miliardi, è materia di polemica politica e anche di implicazioni giudiziarie.