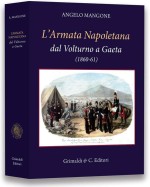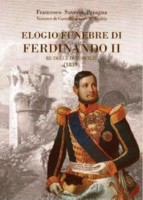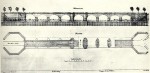Il 10 gennaio 1859, Vittorio Emanuele II re di Piemonte, in conclusione del discorso della corona al Parlamento piemontese, pronunciò la celebre frase del “grido di dolore che da tante parti d’Italia si leva”, che fu il segnale d’apertura della stagione risorgimentale e che servì per giustificare l’invasione, l’occupazione e l’annessione del Regno delle Due Sicilie e del resto d’Italia.
In realtà, stando ai documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Torino e citati da ricercatori, parrebbe che la celebre frase non sia scaturita della vena lirica di Vittorio Emanuele (effettivamente poco incline alle raffinatezze della cultura, per quanto si sa) bensì di Napoleone III Imperatore di Francia, e l’ipotesi sarebbe avvalorata dai testi originali con le correzioni a mano di un breve scambio epistolare tra Cavour e i due sovrani, custoditi nell’Archivio piemontese. Per dirla in poche parole, Cavour avrebbe sottoposto a Napoleone il testo del discorso da lui redatto, che si chiudeva così: «Signori Senatori, Signori Deputati! L’orizzonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno non è pienamente sereno. Ciò non sarà per voi argomento di accingervi con minore alacrità ai vostri lavori parlamentari. Confortati dall’esperienza del passato, aspettiamo prudenti le eventualità dell’avvenire».
All’imperatore francese la conclusione non piacque e, nella risposta inviata il 7 gennaio 1859, consigliò le seguenti modifiche: «Questo avvenire non può essere che felice, giacché la nostra politica si appoggia sulla giustizia, sull’amore della libertà, della patria e della umanità: sentimenti che trovano eco in tutte le nazioni civili. Se il Piemonte, piccolo per il suo territorio, conta per qualche cosa nei Consigli d’Europa, si è che egli è grande per le idee che rappresenta e per le simpatie che ispira. Questa posizione senza dubbio ci crea molti pericoli e tuttavia, rispettando i trattati, noi non possiamo rimanere insensibili ai gridi di dolore che vengono a noi da tante parti d’Italia. Fidenti nella nostra unione e nel nostro buon diritto come nel giudizio imparziale dei popoli, sapremo attendere con calma e con fermezza i decreti della Provvidenza». Vittorio Emanuele, infine, adattò il testo nel modo in cui è stato tramandato dalle cronache risorgimentali: «Il nostro paese, piccolo per territorio, acquistò credito nei Consigli d’Europa perché grande per le idee che rappresenta, per le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli, giacché, nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d’Italia si leva verso di noi!».
Insomma, Cavour scriveva i discorsi, Napoleone li correggeva e il re galantuomo li pronunciava. Sicché, grazie alla collaborazione di tre “fratelli” (in senso massonico) d’Italia, il grido di dolore che mutò le sorti dell’intera Penisola arrivò dritto dritto da Parigi. Cade così l’ennesimo mito fasullo su cui fu “fatta l’Italia”!
In fondo la cosa non dovrebbe destare molta meraviglia visto che, uscendo dalle favole risorgimentali ed entrando nella realtà dei documenti storici, gli italiani degli Stati preunitari non avevano di che dolersi, e meno di tutti i popoli delle Due Sicilie.
I documenti, infatti, ci dicono che nel 1859 il Regno delle Due Sicilie aveva un debito pubblico di circa 5 milioni di lire di allora, mentre quello piemontese ammontava già a 58 milioni.
La rendita dei titoli dello Stato napoletano era una delle più solide al mondo, quotata alla borsa di Parigi al 120%; il tasso di sconto praticato dalle banche era del 5%, il più basso della penisola. Quella di Napoli era la prima Borsa Merci e seconda Borsa Valori dell’Europa continentale; nel Regno era attivo il più alto numero di Società per Azioni d’Italia e vi era la più vasta rete di sportelli bancari. Il ducato napoletano, coniato dal 1140, era da sette secoli la moneta di scambio il tutto il bacino del Mediterraneo; una fede di credito rilasciata dal Banco di Napoli era valutata sui mercati internazionali fino a quattro volte il suo valore nominale, garantita dal deposito in lire-oro maggiore d’Italia (il patrimonio degli Stati preunitari ammontava a 668 milioni di lire-oro, di cui 443 milioni erano napoletani).
Il Tesoro delle Due Sicilie, il più ricco d’Italia, dopo l’unificazione fu trasferito immediatamente a Torino insieme al patrimonio privato della Casa Borbone che ammontava a 30 milioni di lire dell’epoca mai più restituiti. Ai napoletani, invece, fu lasciato un buco di 127 milioni di lire dell’epoca, prodotto in soli quattro mesi dal dittatore Garibaldi fra ruberie, elargizioni, donazioni e pensioni, a cui furono aggiunte le spese di guerra e i danni provocati dalla “liberazione”.
Il Regno d’Italia, quindi, fu inaugurato con un debito pubblico di 182 milioni di lire (oltre 500 milioni di euro), tutto a danno di quelle che erano divenute le “provincie meridionali”.
Il Regno napoletano, fra tutti gli Stati italiani, vantava il sistema fiscale con il minor numero di tasse: ve ne erano soltanto cinque. L’unica imposta diretta era la fondiaria, tutte le altre erano indirette, come registro e bollo, lotterie,poste e procacci, dazi su tabacchi, sale e alcuni prodotti industriali di importazione.
Le fasce meno abbienti della popolazione, totalmente esentate da qualunque imposta, potevano usufruire di circa 700mila ettari di terre sulle quali perdurava il retaggio medioevale degli usi civici, a disposizione del popolo minuto per cacciare, per far pascolare le greggi, per raccogliere legna, paglia, frutti, funghi, ghiande ed erbe.
Inoltre, come in ogni società ordinata sul modello tradizionale, numerose erano le aggregazioni spontanee di cittadini che provvedevano a se stessi e agli altri, corpi sociali intermedi come le associazioni professionali e di lavoro, le confraternite, le società di mutuo soccorso.
Qualora la necessità sociale richiedesse un intervento che superava le possibilità dei singoli e delle aggregazioni intermedie, in perfetta applicazione del principio di sussidiarietà, interveniva direttamente l’apparato dello Stato.
Erano nate così opere monumentali come, ad esempio, il Real Albergo dei Poveri, enorme struttura edificata dal Re Carlo (su disegno di uno dei maggiori architetti dell’epoca, Ferdinando Fuga, perché utile e bello erano concetti che non si escludevano), che dava ricovero fino a mille persone e che aveva al proprio interno varie scuole di arti e mestieri per offrire una possibilità di riscatto dall’indigenza attraverso l’apprendimento di un lavoro.
È il caso anche delle opere di bonifica dei terreni paludosi voluta da Ferdinando II che, attraverso la compartecipazione tra proprietari terrieri e regia amministrazione, recuperò 338mila ettari tra la Puglia e Campania. Una consistente parte di essi fu affidata in enfiteusi a famiglie contadine nullatenenti, insieme al necessario per avviare le coltivazione: nella sola zona del Volturno furono distribuiti 18mila ettari di terra a 1.300 famiglie. La colonia di San Ferdinando di Puglia (FG), la cittadina di Battipaglia (SA) e altri insediamenti nel casertano e in Calabria sorsero proprio a seguito delle bonifiche ferdinandee.
Infine, sempre nel campo dell’assistenza ai bisognosi, non vanno dimenticate le inesauribili opere caritative della Chiesa, che spaziavano dagli ospedali alle scuole parrocchiali, dagli orfanotrofi agli ospizi, dagli asili per i figli dei lavoratori alle associazioni per procurare la dote alle ragazze povere.
C’era, dunque, di che stare tranquilli non certo di che dolersi per i popoli meridionali, prima che i piemontesi decidessero di correre in loro “soccorso”.
Invece, fin dal primo anno di unificazione, il neonato Stato italiano introdusse ben 36 nuove imposte ed elevò quelle già esistenti. La più invisa alla popolazione fu la tassa sul macinato, detta tassa sulla miseria. In soli quattro anni, per gli italiani del Sud la pressione fiscale aumentò dell’87%.
Anche il costo della vita aumentò fino al 40% in più rispetto al 1860, mentre i salari persero il 15% del potere d’acquisto. Il reddito pro capite dei meridionali, allineato alla media degli Stati italiani alla vigilia dell’invasione, iniziò un’inesorabile discesa: a distanza di un secolo era divenuto la metà di quello delle regioni settentrionali.
Se questi dati non bastassero a far sorgere qualche dubbio su quel grido di dolore, si potrebbe parlare del settore produttivo che nel 1859 era in maggiore espansione, l’industria.
Il Regno napoletano era il terzo tra i paesi più industrializzati e, stando al primo censimento italiano del 1861, il comparto artigianato-industria-servizi-terziario occupava circa un milione e duecentomila addetti, il 12% della popolazione totale (10 milioni di abitanti), quando in Piemonte e Liguria gli addetti all’industria erano 345.563 e in Lombardia 465.003.
Il solo nome di Pietrarsa è sufficiente ad indicare il livello tecnologico raggiunto nel settore metalmeccanico. Le sue officine davano lavoro a 1050 operai quando l’Ansaldo di Genova ne contava soltanto 480 e la Fiat non esisteva neppure. L’alta qualità della produzione e la specializzazione in metodi di lavorazione all’avanguardia, ne fecero un modello da studiare ed imitare persino per inglesi e francesi, che venivano nelle officine di Portici per stages di osservazione.
Per rimanere nel settore industriale, ma spostandoci sul mare, si possono ricordare i cantieri navali di Castellammare di Stabia (2000 addetti) con primo bacino di carenaggio in muratura d’Italia, l’Arsenale di Napoli (1600 operai) e un altro centinaio di officine meccaniche distribuite sull’intero territorio. Il Regno vantava la prima flotta mercantile d’Italia, con il maggiore movimento di importazione/esportazione; la prima compagnia di navigazione a vapore nel Mediterraneo, la prima nave a vapore del mondo, la prima nave da crociera in Europa, il primo piroscafo del Mediterraneo che raggiunse l’America con una traversata di 26 giorni.
Ma, con identici risultati, si possono citare anche altri settori produttivi, come le industrie tessili (che fornivano la Casa Reale inglese e l’Esercito Francese), cartarie, del vetro, delle pelli e del cuoio (700mila dozzine di paia di guanti esportati), chimiche, estrattive, alimentari (300 pastifici che esportavano in tutto il mondo e gli oleifici pugliesi che avevano il marchio doc sin dal 1844), tipografiche (113 stamperie solo nella città di Napoli).
L’organizzazione sociale del lavoro era tanto avanzata che nel Regno era stato istituito il primo sistema pensionistico in Italia, con la ritenuta del 2% sugli stipendi.
Dopo l’unificazione, l’industria napoletana fu lasciata letteralmente languire, affamata dall’abbattimento dei dazi troppo repentino per un settore giovane e in piena espansione e dalla mancanza di commesse statali, assegnate ad aziende del Nord in proporzione vergognosa. Infatti, a fronte di un prelievo fiscale pari al 40% del totale delle entrate dello Stato, gli opifici meridionali ottennero soltanto il 6% delle commesse militari ed industriali relative a lavori pubblici.
Per non dire della politica dei trasporti attuata dai Governi italiani, che tagliò completamente le gambe ai mercati del Sud. Superfluo ricordare che la prima ferrovia in Italia fu la Napoli-Portici; necessario invece dire che nel 1860 erano attivi 132 chilometri di strada ferrata ed altrettanti erano in fase di ultimazione, mentre altri 1400 erano già progettati e finanziati. Avrebbero dovuto collegare le zone interne del paese con le coste, e soprattutto la Puglia con il Tirreno, in previsione degli sbocchi commerciali prospettati dalla prevista apertura del Canale di Suez (inaugurato nel 1864).
Ma al nuovo Regno d’Italia il Mediterraneo importava poco, i suoi interessi economici erano continentali e le uniche vie potenziate furono quelle dell’asse verticale nord-sud sulle direttrici costiere. Intere stazioni ferroviarie furono smantellate pezzo per pezzo, dopo l’assorbimento delle ferrovie napoletane da parte di tre società settentrionali a capitale per lo più straniero, e il materiale rotabile ricavato fu utilizzato altrove.
Ancora oggi le regioni meridionali pagano lo scotto di quella disastrosa politica e gli imprenditori del Nord lamentano la “mancanza di infrastrutture” come se fosse dovuta ad una colpevole arretratezza del Meridione.
Se qualcuno nutrisse ancora perplessità a proposito del grido di dolore, qualche dato di natura non economica sarà certamente illuminante per delineare un quadro di diffuso benessere e di alto livello civico, visto che il Regno delle Due Sicilie, al momento dell’invasione, vantava oltre 60 primati italiani, europei e mondiali.
Sul piano sociale, infatti, presentava il più basso tasso di mortalità infantile d’Europa; il più alto numero di medici per abitante d’Italia; il più alto numero di amnistiati politici; le prime “case popolari”; la prima assistenza sanitaria gratuita; la prima vaccinazione di massa; la più alta percentuale di orfanotrofi, ospizi, collegi, conservatori e strutture di assistenza e formazione, in rapporto alla popolazione.
Sul piano culturale e scientifico, le Due Sicilie annoveravano: le prime cattedre universitarie europee di Astronomia, Economia e Architettura; il primo Codice Marittimo e il primo atlante marittimo del mondo; i primi Orto Botanico, Osservatorio Astronomico, Museo Mineralogico, Centro Sismologico, Osservatorio Meteorologico, Ospedale Psichiatrico, d’Italia; il primo esperimento di illuminazione elettrica, il primo telegrafo elettrico, il secondo ponte in ferro del mondo ed il primo a campata sospesa; il primo faro lenticolare a luce costante; un numero incredibile di brevetti europei e mondiali in tutti i settori produttivi e commerciali.
La capitale del Regno, Napoli, era la città più popolosa d’Italia con 447.065 abitanti (Torino: 204.715; Roma: 194.587), prima anche per numero di teatri, di conservatori musicali, di giornali e riviste pubblicati. Era stata la prima ad avere un piano regolatore e la terza città europea ad avere l’illuminazione pubblica a gas (350 lampade), dopo Londra e Parigi.
Questo lungo elenco di primati, e tutti gli altri che ancora aspettano di riemergere dai fasci degli archivi dove giacciono dimenticati, portano a tre semplici deduzioni:
– da un Regno con tale livello economico e civile, è certo che nessun grido di dolore poteva levarsi;
– se per assurdo ciò fosse accaduto, è altamente improbabile che la richiesta di aiuto sarebbe stata indirizzata al Regno di Sardegna, tanto inferiore sul piano economico, sociale e militare;
– è destinata a rimanere enormemente al di sotto della realtà qualunque ipotesi circa l’opera di infiltrazione della massoneria e la quantità di danaro che furono necessari per seminare corruzione e tradimento in un Regno tanto ricco e progredito.
Ultime due annotazioni, a conferma finale di quanto detto finora.
Nella storia delle Due Sicilie, sollevazioni popolari che abbiano avuto l’estensione territoriale, la durata nel tempo e la partecipazione numerica del fenomeno conosciuto come brigantaggio, si sono verificate soltanto in due occasioni: nel 1799, all’arrivo delle truppe francesi di Championnet, e nel 1860, all’arrivo dei garibaldini prima e dei piemontesi dopo.
In entrambi i casi, dunque, si trattò di invasioni straniere nelle quali gli invasori trovarono collaborazione tra la nobiltà e le classi dirigenti corrotte, mentre il popolo si sollevò in difesa della monarchia borbonica e combatté per la restaurazione.
Fino al 1860, il Regno napoletano aveva un tasso di emigrazione pari a zero; piuttosto era terra di immigrazione qualificata e di significativi investimenti economici stranieri.
Tra il 1870 e il 1913, emigrarono all’estero 5 milioni di meridionali, con una crescita annua graduale ed inesorabile, prima verso i paesi europei e, a partire dal 1880, soprattutto verso gli Stati Uniti. Secondo dati raccolti dall’Università La Sapienza di Roma, in trentacinque anni furono 15 milioni gli italiani che emigrarono nelle Americhe.
Nel solo 1913, su una popolazione totale che non arrivava a 30 milioni, ben 872.598 italiani andarono a cercare fortuna lontano dalla patria, e 376.776 di essi sbarcarono ad Ellis Island (New York – USA).
Tante furono le vere grida di dolore che si levarono da tutte le parti d’Italia, ma solo dopo l’unità.
Potrebbe interessarti anche:
Perchè non festeggiamo l’unità d’Italia
I peggiori 150 anni della nostra storia