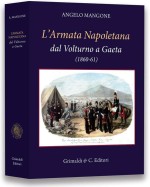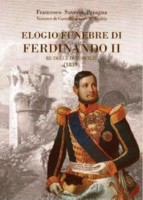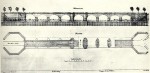Le bugie di certa storiografia lo presentano come il regno della miseria e dell’oppressione. Invece il Regno delle Due Sicilie aveva un invidiabile sistema di solidarietà, un bilancio migliore di tanti altri Stati e, fatto unico in Europa e nel mondo, dopo la rivoluzione del 1848 non condannò a morte nessuno.
È una costante matematica: chi più discetta di morale, meno la pratica. La prova del nove? I Savoia ed i liberali. Ad ogni piè sospinto Cavour e compagni esaltano la moralità del governo costituzionale e liberale che incarnano ed esecrano il malaffare, l’oscurantismo e la tirannide caratteristiche, a loro modo di vedere, del governo pontificio e borbonico.
Pur di suscitare lo sdegno internazionale (ancora oggi il popolo della sinistra non si stanca di esibire il proprio sempiterno sdegno) contro lo Stato della Chiesa e contro il Regno delle Due Sicilie, Camillo Benso conte di Cavour si mette d’accordo con lord Clarendon, ministro degli esteri di Sua Maestà. Ecco cosa gli scrive il 31 marzo 1856: «Vi prego di presentare al Congresso la seguente proposta in favore degli sfortunati concittadini che gemono nelle prigioni e nelle galere dei principi italiani». Il presidente del Consiglio del regno sardo vuole usare la platea internazionale del Congresso di Parigi per preparare gli animi alla necessaria, moralizzante, invasione sabauda di tutti i regni d’Italia e il compito assegnato a Clarendon è quello «di invitare i sovrani d’Italia ad accordare un’amnistia e ad adottare misure di clemenza nei confronti dei sudditi condannati per motivi politici in seguito agli avvenimenti del 1848 e ‘49».
È vero che Ferdinando di Borbone e Pio IX fanno gemere nelle loro carceri i terroristi – detti patrioti – che hanno attentato alla loro vita e a quella dei loro sudditi nella preparazione dei moti insurrezionali? A tener conto dei dati no. Dopo la rivoluzione del 1848, nel Regno delle Due Sicilie, fatto unico in Europa e nel mondo, non ci sono condanne a morte. Paolo Mencacci, nelle Memorie Documentate pubblicate nel 1879, racconta che dei 42 casi di condanne a morte per delitti politici decretati dalle Corti di giustizia negli anni che vanno dal 1851 al 1854, Ferdinando ne tramuta diciannove in ergastoli, undici in 30 anni ai ferri, dodici in pene minori. Nessuna esecuzione capitale. Negli stessi anni la clemenza del sovrano grazia 2.713 condannati per reati politici e 7.181 per reati comuni. Succede il contrario nel Regno di Sardegna. È il ministro De Foresta a rendere pubblico il raffronto fra le esecuzioni eseguite in un quinquennio di governo liberale (anni 1851-55) e quelle avvenute in un quinquennio di governo assoluto (1840-44): 113 contro 39.
Il confronto fra Regno di Sardegna e Regno delle Due Sicilie è perdente da molti punti di vista. Se Cavour, nel 1846, scrive di ferrovie e della necessità di costruirle, Ferdinando II ha già operative le tratte Napoli-Castellammare e Napoli-Capua.
Tanto è oculata l’amministrazione borbonica, quanto è fuori controllo quella sabauda. In soli dodici anni, dal 1848 al 1860, il Regno di Sardegna accumula un deficit di bilancio di 1.024.970.595 lire. Scrive don Margotti sull’Armonia del 20 novembre 1855: «Da sette anni in qua il ministero domanda imprestiti e progetta imposte; la Camera discute, vota ed approva, i contribuenti pagano».
L’esatto contrario succede a Napoli dove le spese previste sono sistematicamente inferiori a quelle effettuate. Ecco cosa scrive L’Archivio economico dell’unificazione italiana edito nel 1956: nel quinquennio 1854-58, ad un disavanzo complessivo previsto in 18.192.000 ducati, corrisponde un disavanzo di soli 5.961.000 ducati, meno di un terzo della somma preventivata. Come i disavanzi, «anche gli introiti presunti erano generalmente inferiori a quelli effettivamente realizzati. Ciò accadeva perché i bilanci preventivi venivano compilati con grande circospezione».
A Napoli, scrive don Margotti, «il debito pubblico è minimo, e le cartelle appartengono quasi esclusivamente ai regnicoli […]. L’imposta fondiaria a Napoli è dolcissima»; la Sicilia è «esente dalla leva militare, che è un’imposta di sangue, dall’imposta sul sale, e dal monopolio del tabacco»; il “barbaro” Ferdinando ha «stabilito nei maggiori centri della popolazione monti frumentari per somministrare grano agli agricoltori da seminare e per mantenersi colle loro famiglie, tagliando così in pari tempo le gambe all’usura».
Il comportamento dei regnanti napoletani non potrebbe essere più diverso da quello del conte di Cavour, principale azionista della Società Anonima dei Molini anglo-americani di Collegno, che lucra sulla vendita di grano all’estero in tempi di carestia.
Ho sotto gli occhi un documento straordinario che testimonia nel modo più inconfutabile la cura amministrativa dei Borbone: si tratta di una copia dello Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno 1857 che devo alla sollecitudine professionale del mio amico Giuseppe Fioravanti, docente di Storia della Scuola. In centinaia di pagine sono elencate, in buon ordine, tutte le innumerevoli attività industriali, economiche, assistenziali, scolastiche, del Regno delle Due Sicilie, con i nomi dei relativi responsabili.
È descritta, all’opera, la sollecitudine di un sovrano per il buon governo. Un governo che organizza capillarmente l’assistenza ai poveri, che, fra le tante iniziative, prevede anche borse di studio per gli studenti bisognosi.
Borse di studio che un decreto illuminato del governo garibaldino prontamente abolisce per manifesta immoralità. Il 26 ottobre 1860, da Napoli, in nome di Vittorio Emanuele II Re d’Italia, firmato dal Prodittatore Giorgio Pallavicino e dal Ministro dell’Interno Raffaele Conforti, viene promulgato il Decreto n. 189, col quale il fondo assegnato per soccorsi agli studenti e letterati poveri viene destinato ad altro uso. Proprio così. Questa la motivazione: «Considerando che non vi è niente di più vergognoso che domandare ed accettar limosina sotto il nome di studente o letterato povero» si decide che «i soccorsi agli studenti e letterati poveri sono tolti».
Cosa importa al moralista governo invasore dell’istruzione dei poveri? E infatti i poveri, in umili ed interminabili carovane, saranno costretti all’emigrazione in massa. Cosa inaudita nel Bel Paese che per più di due millenni non è stato solo bello ma anche ricco. Quando Francesco II, figlio di Ferdinando II al quale era succeduto nel 1859, da Gaeta, l’8 dicembre del 1860 – la data è significativa – scrive ai popoli delle Due Sicilie, si limita a fotografare la realtà: «Sono un principe ch’è il vostro e che ha tutto sacrificato al desiderio di osservare tra i suoi sudditi la pace, la concordia, la prosperità […] Ho creduto in buona fede che il re del Piemonte, che si diceva mio fratello e mio amico, che si protestava disapprovare l’invasione di Garibaldi […] non avrebbe rotto tutti i trattati e violate tutte le leggi per invadere tutti i miei Stati in piena pace, senza motivi né dichiarazioni di guerra […]. Le finanze non guari sì fiorenti, sono completamente ruinate, l’amministrazione è un caos, la sicurezza individuale non esiste. Le prigioni sono piene di sospetti, in luogo della libertà, lo stato d’assedio regna nelle province e un generale straniero pubblica la legge marziale decretando le fucilazioni istantanee per tutti quelli dei miei sudditi che non s’inchinano innanzi alla bandiera di Sardegna […]. Uomini che non hanno mai visto questa parte d’Italia […] costituiscono il vostro governo […] le Due Sicilie sono state dichiarate province d’un regno lontano. Napoli e Palermo saranno governate da prefetti venuti da Torino».