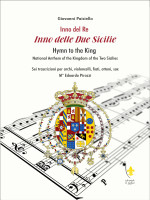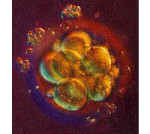Lo Stato centralista
Lo Stato italiano, così come lo conosciamo, è un’eredità del giacobinismo e del periodo napoleonico, imposto dal Piemonte agli Stati pre-unitari all’atto dell’unificazione forzata della penisola.
A dispetto della diffamante rappresentazione dell’apparato statale del Regno delle Due Sicilie mediante l’appellativo “borbonico”, rimasto ancora oggi un luogo comune privo di nessi storici, fu lo Stato di Sardegna ad estendere alle terre conquistate la burocrazia farraginosa della “triplice copia”, eredità dei rivoluzionari francesi.
Una burocrazia cieca affidata a travet anonimi, che dovevano applicare meccanicisticamente regolamenti e leggi, che codificavano qualsiasi aspetto della vita e del comportamento umano, ed operare un continuo controllo sanzionatorio.
Generato dalla mentalità giacobina, lo Stato italiano ha considerato i cittadini come amorfi e solitari individui, ed ha stabilito con essi un rapporto di sospetto e sfiducia, perché basato non sulla verità ma sulla visione ideologica della realtà.
Infatti, lo Stato unitario ha cercato di cancellare qualunque retaggio tradizionale, ha uniformato tutto, incurante delle differenze storiche, culturali, linguistiche, delle autonomie locali, dei corpi intermedi, persino delle differenze ambientali e climatiche. Ha preteso che l’Italia, penisola lunga 1300 chilometri, fosse una “dalle Alpi a Pantelleria”, e dividendo i sudditi in obbedienti o renitenti.
Inutile dire quanto questo sia stato penalizzante per il Meridione, che dopo aver subito la perdita della libertà e della sovranità, dopo aver patito la spoliazione di beni e ricchezze ed essere stato confinato al ruolo di colonia, fu sottoposto a leggi speciali che dovevano stroncare ogni memoria dell’identità e della storia e rendere docile, con la forza, chi tardava a sottomettersi al nuovo regime.
La scuola pubblica ebbe il compito di compiere l’opera uniformante nelle generazioni successive, e ancora oggi ne vediamo gli effetti. La mitologia risorgimentale è stata inoculata sui banchi di scuola e, con essa, l’idea di un Sud in permanente inferiorità, col cappello in mano. Un Sud che dall’Italia era stato liberato, poi civilizzato, infine sfamato, e che, ingrato!, non era capace di abbandonare vizi ed ozii endemici.
Un formidabile contributo al processo di snaturamento, certamente involontario, arrivò anche dall’emigrazione, non per nulla favorita dallo Stato (si pensò persino di trasformarla in deportazione) che non tardò a sfruttarne i benefici, visto che in pochi anni le “rimesse dall’estero” divennero una voce importante del bilancio nazionale.
Non è mai stato fatto – e invece si dovrebbe – uno studio per valutare, in termini psicologici e culturali più ancora che economici, il costo dell’emorragia emigratoria per chi rimase nelle “provincie della Bassa Italia”. Interi paesi abitati solo da donne, bambini e anziani, sottoposti all’abuso di chi governava in nome e per conto di uno Stato rapace e violento, che aveva stipulato patti con mafia e camorra per assicurarsi il controllo del territorio. Povera gente, vessata dalle tasse e dal sospetto, che aveva perso padri, figli e fratelli, prima uccisi o incarcerati e poi emigrati. Famiglie spezzate partite per l’America, il Brasile, l’Argentina e famiglie smembrate che non avevano più le forze per coltivare la terra, ridotte alla miseria e al silenzio, alla paura. Bambini cresciuti imparando che a casa loro non avrebbero avuto mai niente e che l’unica speranza era “la merica”.
Da chi era formata la classe dirigente meridionale dell’Italia unificata? Da liberali e massoni, certamente, perché tutti gli altri erano accusati di borbonismo, e poi da capibastone o loro manutengoli. Ma soprattutto fu formata da italiani d’accatto, approfittatori che videro l’occasione per fare affari, per mantenere o avere terre, per salire la scala sociale, per conquistare potere. Gattopardi e iene, pronti ad ogni compromesso, proni ad ogni politica nazionale, per quanto dannosa potesse essere per quella che era stata la loro Patria.
Non sono bastate due guerre mondiali per cambiare le cose, e anche con la Repubblica l’atteggiamento politico e culturale nei confronti del Sud non è cambiato sostanzialmente. Sono cambiate le forme, ma la retorica politica e i compromessi, la convivenza con la criminalità e la sistematica spartizione, quelle non sono cambiate.
Non è cambiata la classe politica, anzi, e si è mimetizzata ancor di più dietro le sigle dei partiti.
La Cassa per il Mezzogiorno, le opere pubbliche interminabili, le cattedrali nel deserto economico, non hanno forse alimentato la corruzione, la connivenza tra politica e malaffare? E la mentalità che le ha volute non è forse sempre stata quella di un’economia assistenzialista, che doveva sfamare la manovalanza locale ma doveva portare i capitali al Nord? Persino le disgrazie, come i terremoti, sono servite ad alimentare questo circuito.
Lo stesso dicasi per i piani di “industrializzazione” del Sud, progettati per industrie aliene al territorio, slegate dalla tradizione e ignare dei limiti imposti dalla mancanza di infrastrutture, che hanno favorito le industrie del Nord con notevoli sgravi fiscali e finanziamenti a fondo perduto, e hanno dato come unico prodotto centinaia di cassaintegrati, per decenni abbandonati alla pubblica beneficenza.
Il “Sistema Italia” appare da sempre in un permanente disequilibrio, che se scontenta tutti, per il Sud è certamente più penalizzante. Soprattutto se si pensa a quale fosse la situazione economica e sociale, la dignità e il riconoscimento internazionale di cui godeva il Regno delle Due Sicilie fino all’alba della conquista.
Ed è paradossale che le spinte ad un recupero di identità e di autonomia siano venute, da molti anni in qua ormai, da un Nord che si sente limitato dal Meridione visto come “palla al piede”, piuttosto che da un Sud che dovrebbe aver recuperato orgoglio e voglia di riscatto, grazie all’enorme lavoro di revisione storica svolto negli ultimi trent’anni.
L’autonomia differenziata
L’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario è riconosciuta dall’art. 116 della Costituzione, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. Volle essere il primo passo verso quel “federalismo” richiesto a gran voce dai partiti la cui base era al Nord.
L’art. 116 prevede che le Regioni possano attribuirsi poteri in più di 20 materie differenti, configurando un “regionalismo differenziato o asimmetrico”. Tra le venti materie a cui si può applicare, ve ne sono alcune che rappresentano esigenze principali per il Sud: la gestione dei beni culturali, istruzione, tutela dell’ambiente, alimentazione, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionali, rapporti internazionali e con l’Unione Europea, commercio con l’estero; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione.
L’iter viene avviato dalla Regione, che fa richiesta dell’autonomia rinforzata nelle materie di suo interesse, e perviene ad un’intesa con lo Stato, acquisito il parere degli Enti Locali interessati, approvata infine dal Parlamento.
Allo stato attuale, nove regioni su venti hanno chiesto maggiore autonomia: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania. Quest’ultima è l’unica regione del Sud ad aver espresso il proprio interesse sulla questione.
Nel 2017, in Lombardia e Veneto si sono svolti anche dei referendum che hanno confermato a larga maggioranza dei votanti la richiesta di autonomia; i votanti però sono stati soltanto, rispettivamente, il 38 e il 57% degli abitanti delle due regioni.
In Campania si è rimasti fermi alle consultazioni preliminari e non si è arrivati a formalizzare una richiesta ufficiale di autonomia al Governo. Invece, nel 2019, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sono giunte alla fase di definizione dell’intesa con il Governo. Con l’attuale governo Pd-M5Stelle, poco favorevole all’autonomia differenziata, però, la trattativa è entrata in una fase di stallo e l’emergenza Covid-19, che ha bloccato l’intero Paese nei primi sei mesi di quest’anno (2020), ha fermato del tutto i progetti autonomistici avviati, probabilmente definitivamente.
Nell’estate del 2019 si è sviluppato un intenso dibattito politico e mediatico sulla questione, partendo ovviamente da punti di vista opposti in base alla latitudine.
Al Nord, l’argomento principe a favore dell’autonomia differenziata è stata la perdita in termini di residuo fiscale, cioè tra quanto ogni cittadino settentrionale versa in tasse e quanto riceve in servizi pubblici. Il calcolo non è facile da stimare e la polemica ha fatto oscillare questa differenza tra 30 e 57 miliardi di euro. In poche parole, secondo chi sostiene questa tesi, un milanese vedrebbe decurtati, dalle tasse che paga, 5.600 euro per i quali non riceverebbe servizi, mentre un calabrese si vedrebbe messi a disposizione servizi che non ha finanziato con le sue tasse, per un ammontare di 5.500 euro (Il Sole 24Ore, 20/02/2020).
L’autonomia differenziata potrebbe ridurre lo squilibrio tra entrate ed uscite pubbliche, perché una parte maggiore del gettito fiscale verrebbe trattenuta e utilizzata nel territorio dal quale viene erogata. Sono previsti, però, dei meccanismi di riequilibrio e di compensazione ad impedire che, per mancanza di fondi, non sia possibile erogare servizi indispensabili nelle regioni con redditi più bassi.
Al Sud, la polemica è diametralmente opposta e si è concentrata soprattutto sul problema delle minori risorse rese disponibili, in Regioni in cui i servizi sono già cronicamente carenti, e della regolazione del fondo di perequazione che dovrebbe bilanciare il minor gettito.
In generale, nell’accesa polemica dello scorso anno, sostanzialmente hanno prevalso i toni contrari all’autonomia differenziata delle Regioni. Addirittura, in un rigurgito ultra-statalista, si è giunti a mettere in discussione l’esistenza stessa delle Regioni. Al Sud, contro l’autonomia si sono schierati i maggiori quotidiani “Il Mattino” (diretto dal giugno 2018 dal piemontese Federico Monga) e “La Gazzetta del Mezzogiorno”, e il presidente dello Svimez Adriano Giannola e l’economista Gianfranco Viesti.
Il timore maggiore può essere sintetizzato nel formalizzare giuridicamente l’esistenza di “cittadini di serie A e serie B”. Va detto, ad onor del vero, che se questa differenza, di fatto, è già parte della vita quotidiana degli italiani del Sud. Un solo esempio: tutti coloro che devono andare a curarsi negli ospedali del Nord, nonostante esista un Sistema Sanitario Nazionale, teoricamente uguale ed efficiente in tutte le Regioni, che in particolare durante l’emergenza Covid-19 è stato esaltato come “eccellente”. L’altro timore più o meno esplicito nel Sud è di essere, ancora una volta, defraudato a favore del Nord, senza essere mai stato risarcito di quanto già tolto.
Con uno sguardo più distaccato, però, l’impressione è che, al di là degli aspetti tecnici ed economici che pure sono di grande impatto, il problema sia l’idea stessa dell’autonomia. E che forse il dibattito sia condizionato dagli elementi culturali che hanno segnato la nascita e lo sviluppo dell’Italia unitaria.
Alla fine si tratta di quale idea di Stato si ha in mente e delle possibili vie per realizzarlo.
Ne abbiamo parlato con il Prof. Carlo Lottieri, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Verona e Filosofia della Scienze sociali alla Facoltà Teologica di Lugano;
con la Prof.ssa Carmela Maria Spadaro, docente di Storia del Diritto all’Università Federico II di Napoli e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Il Giglio;
con il Prof. Gennaro De Crescenzo, docente di Italiano e Storia negli Istituti Superiori, autore di numerosi saggi sulla storia delle Due Sicilie e Presidente del Movimento Neoborbonico.