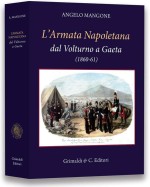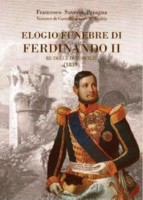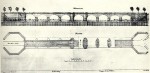“Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili: Sono convinto di non aver fatto male, nonostante ciò non rifarei la via dell’Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio” (G. Garibaldi).
Questa vera e propria confessione del cosiddetto “eroe dei due mondi” la dice lunga su quello che è stata l’occupazione piemontese delle regioni già facenti parte del Regno delle Due Sicilie.
Un’occupazione tanto feroce da farsi bollare per bocca di un politico non certo sospettabile di simpatie reazionarie, Antonio Gramsci, con queste terribili parole: “Lo Stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare con il marchio di briganti”.
In realtà non furono solo i contadini poveri a pagare il prezzo dell’occupazione sabauda. Una sorte terribile toccò infatti anche a quelle decine di migliaia di soldati, sottufficiali e ufficiali dell’esercito duosiciliano che vollero rimanere coraggiosamente fedeli al loro Re, rifiutando il giuramento di obbedienza alle nuove autorità italiane.
Molti di loro vennero rinchiusi nelle carceri e nei depositi di Napoli, ma la maggior parte venne stipata come bestie su navi militari e trasferita a Genova. Da lì, vennero smistati nelle carceri di tutto il Nord, da Alessandria fino a Bologna.
Se le condizioni di detenzioni in questi penitenziari erano a dir poco spaventose, questi disgraziati possono essere considerati dei fortunati in confronto a quei circa settemila prigionieri che ebbero in sorte di essere inviati in una tetra fortezza nel cuore delle Alpi piemontesi: il forte di Fenestrelle, nell’alta Val Chisone, a quasi duemila metri di altezza.
L’enorme costruzione di Fenestrelle era stata ultimata nel ‘700 allo scopo (fallito) di fungere da barriera alle eventuali invasioni francesi ed era composta da una serie di fortini collegati tra di loro da una interminabile scala scavata nella roccia e protetti da altissimi bastioni.
La vita in quello che oggi chiameremmo super-carcere di Fenestrelle era contraria alle più elementari norme di umanità e rivelava tutto l’odio con cui i “rivoluzionari” trattano in ogni epoca coloro che si oppongono ai loro progetti. Le finestre erano senza vetri, i prigionieri vestivano di cenci e dormivano su pagliericci o, più spesso sui pavimenti di fredda pietra delle celle. Il cibo era costituito da una brodaglia immangiabile.
I fisici di persone abituate ai miti climi del Sud Italia non ressero a lungo al freddo clima alpino ed i prigionieri cominciarono ad ammalarsi, ma di assistenza medica ovviamente non era neanche da parlare (altro che Maroncelli detenuto alla fortezza dello Spielberg, che poté avvalersi del miglior chirurgo di Vienna per operarsi di un tumore!).
I detenuti cominciarono quindi a morire come le mosche e i loro corpi venivano gettati dentro a fosse piene di calce viva, nel retro della Chiesa che sorgeva all’ingresso del forte. Cosa avvenisse dei miseri resti non è dato di sapere, ma si può dedurre da notizie raccolte qui e là. Per esempio, fonti inglesi che nulla hanno a che fare con la storia della repressione sabauda ma piuttosto con l’economia, rilevano che in anni successivi all’unificazione, il commercio di ghiaia e terricci da costruzione dal Piemonte verso l’Inghilterra attraversò un periodo di crisi a causa della scadente qualità della merce, piena di corpi estranei come frammenti d’ossa e bottoni metallici delle divise militari. Evidentemente, le vasche di calce di tanto in tanto venivano svuotate e il contenuto, buttato giù dalla rupe, scendeva più a valle con le nevi disciolte.
La morte era l’unico modo di sfuggire alla prigionia: non risulta che a Fenestrelle siano mai avvenute scarcerazioni.
Persino i registri dei prigionieri erano mal tenuti, lacunosi e poco aggiornati: segno che le autorità consideravano la detenzione nel forte come “definitiva” e che alle famiglie dei detenuti non fosse concesso neppure di conoscere la sorte del congiunto.
Il 22 agosto del 1861 vi fu un tentativo di rivolta dei prigionieri, scoperto e sventato dai piemontesi. Per rappresaglia le condizioni di detenzione furono ulteriormente inasprite e ai disgraziati militari duosiciliani fu imposto di portare incatenata ai piedi una palla di metallo del peso di sedici chili.
In queste condizioni, prigionieri malati e denutriti dovevano salire la lunga l’interminabile scalinata che percorre tutto il forte. La detenzione si protrasse ben oltre il periodo bellico e, di fatto, nessun prigioniero ebbe la fortuna di far ritorno alla propria casa.
Tra i tanti “meriti” dei Savoia si può quindi annoverare anche quello di aver inaugurato il primo campo di sterminio della storia. Non è un caso che entrando nella fortezza sia ancora oggi visibile una scritta (che ne ricorda un’altra più celebre, pure posta all’ingresso di un campo di morte e sofferenza): “ognuno vale non in quanto è, ma in quanto produce”. Perfetto motto dell’ideologia che aveva unificato l’Italia calpestando popoli e radici millenarie.
Soltanto l’ultimo passaggio di questa storia dell’orrore non fu portato a termine. Il governo italiano, prendendo a modello quello rivoluzionario francese che aveva trasformato l’invivibile colonia della Cayenna in un carcere a cielo aperto per gli oppositori, cercò un’isola oltreoceano o una landa selvaggia dove deportare i prigionieri. Per questo avviò contatti con l’Argentina, per una lingua di terra all’estremo lembo della Patagonia, ma non raggiunse un accordo soddisfacente dal punto di vista economico.
Solo per questo i Meridionali in Sud America ci arrivarono da emigranti e non da prigionieri.