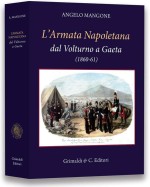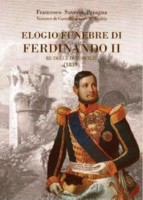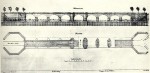di Gennaro De Crescenzo
“Merito la morte perché sono stato assai crudele contro parecchi che mi caddero tra le mani; ma merito anche pietà e perdono perché contro mia indole mi hanno spinto al delitto. Ero sergente di Francesco II e ritornato a casa come sbandato mi si tolse il brevetto, mi si lacerò l’uniforme, mi si sputò sul viso e poi non mi si diede più un momento di pace facendomi soffrire sempre ingiurie e maltrattamenti: si cercò pure di disonorarmi una sorella, laonde accecato dalla rabbia e dalla vergogna non vidi altra via di vendetta che quella dei boschi, e così per colpa di pochi divenni crudele e feroce contro di tutti ma io sarei vissuto, se mi avessero lasciato in pace. Ora io muoio rassegnato, e Dio vi liberi dalla mia sventura”.
Perché divennero briganti? Lo spiega Pasquale Cavalcante di Corleto prima di morire fucilato come uno dei tanti “briganti” del Sud. Ce lo spiega con semplicità e con rabbia: per legittima difesa, per reagire contro un’invasione straniera, per difendere la dignità e l’identità di un popolo.
Nel corso degli anni la storiografia ufficiale ha cercato in ogni modo di giustificare la tragica pagina del “brigantaggio” meridionale post-unitario. Se per la resistenza di una forte tradizione orale locale e per la stessa gravità dei fatti in questione era difficile cancellare completamente queste pagine di storia, bisognava allora ad ogni costo inquadrare i cosiddetti “briganti” in una visione “romantico-risorgimentale”, liberale o marxista. Si fa strada, subito dopo l’unificazione, una lettura che inserisce gli ultimi difensori della Nazione Napoletana tra gli eroi di un “romanticismo” letterario che confonde racconti leggendari e personaggi di secoli diversi, invenzioni romanzesche e mitologie fantasiose: “briganti” e “brigantesse”, allora, uniti a rapimenti o a fughe a cavallo nei boschi, confondono storie e idee in un unico calderone indistinto che niente ha a che fare con la storia vera. Da questa visione prende spunto, forse, la stessa lettura liberale che parte da Croce e arriva, attraverso i famosi “meridionalisti” della prima e dell’ultima ora, fino ad oggi: si minimizzano i fatti, si semplifica la questione e si riduce tutto ad un banditismo diffuso nel Sud da secoli e per secoli con un filo rosso che, secondo alcuni, unisce i delinquenti comuni del periodo spagnolo a quelli dello stesso periodo borbonico, i nostri “briganti” ai più attuali esponenti della camorra.
È con Gramsci e altri storici marxisti, invece, che si cerca di affermare un’altra linea: si concede di più alle stragi e ai massacri compiuti sulla pelle dei meridionali ma, sempre semplificando con superficialità, il fenomeno viene letto come un altro caso di lotta di classe ed un esempio di ribellismo contadino che traeva la sua origine dagli atavici problemi delle plebi meridionali.
Mai come in questo caso, forse, è ancora necessaria una ricostruzione storica obiettiva e scientifica. La storia del “brigantaggio” è ancora tutta da ritrovare negli archivi storici locali e nelle pubblicazioni del tempo, negli archivi militari ancora in parte inutilizzabili e tra quei giornali e quelle riviste che ebbero il coraggio di denunciare quanto stava accadendo nel nostro meridione appena 140 anni fa: in questa direzione può essere preziosa la lettura degli articoli della “Civiltà Cattolica” recentemente pubblicati a Napoli.
Basterebbe leggerne anche solo alcuni per capire che tra il 1860 e il 1870 nei nostri boschi e nelle nostre città non c’erano eroi ed eroine romantiche o contadini delusi e arrabbiati: combattemmo, nella nostra terra, una guerra legittima di liberazione e di resistenza contro una cultura ed un popolo stranieri, difendemmo palmo a palmo, case, terre e famiglie da una rivoluzione che non poteva e non doveva essere nostra, uccidemmo e morimmo come i tanti e sconosciuti eroi di una contro-rivoluzione che ci aveva già visto combattere e morire in Francia o in Spagna, nel 1799 come nel 1820, nel 1848 come nel 1860.
E diventa più che mai necessario utilizzare tutte le fonti che abbiamo a disposizione e che in questi anni sono state usate in modo sempre parziale o condizionato da questa o da quella ideologia: scopriremmo facilmente che “briganti” ve ne furono senza dubbio nelle campagne e sulle montagne di tutta l’Italia meridionale ma “briganti” (o “patrioti” o “legittimisti”) ne potremmo trovare anche nelle città e addirittura nella stessa capitale. Si trattò di una guerra di resistenza e di difesa legittima di se stessi, del proprio Re, della propria bandiera e della propria nazione a Napoli come a Potenza, a Melfi come a Palermo. È ovvio (ma non lo è stato, colpevolmente, per la storiografia ufficiale in tutti questi anni) che per le strade di Napoli o di Palermo non si combatteva nello stesso modo in cui si combatteva tra i boschi della Lucania. Nessuno ha voluto approfondire le rivolte post-unitarie avvenute in Sicilia (famosa quella del “sette e mezzo” nel 1866) né si è andato mai a leggere i documenti, ad esempio, dei fondi della Questura di Napoli: tumulti, violenze, proteste, arresti, non si contavano più: è a Santa Lucia che avvennero i fatti più gravi, da quelle parti sequestrarono diverse copie di un “Appello dei legittimisti” che, tra l’altro, riportava anche le parole dell’Inno Reale (“Iddio conservi il Re…”); erano considerati “pericolosi” i doganieri napoletani; venivano pedinati e sorvegliati quotidianamente ex soldati ed ex impiegati pubblici; furono arrestati parroci e sindaci dei Comuni di Soccavo e di Casalnuovo; fu arrestato Pasquale Matteucci, artefice di una rissa al Ponte di Casanova presso la Ferrovia, per aver gridato “Viva Francesco II”; furono sfrattati e arrestati molti monaci dei conventi di S. Eframo e del Carmine e i parroci che protestarono contro il provvedimento che imponeva la rimozione delle immagini sacre dalle strade; furono trucidati gli operai di Pietrarsa nel 1863 solo perché protestavano contro il governo e cercavano di difendere il loro lavoro.
Si faceva una grande fatica, insomma, a mantenere l’ordine pubblico anche nella stessa capitale nonostante la massiccia presenza di militari: sembravano non bastare i 120.000 uomini inviati da Torino: quale delinquenza comune o quale semplice ribellione contadina poteva costringere i piemontesi quasi a perdere la loro ultima conquista? Quando era accaduto qualcosa di simile con i Borbone o nel resto dell’Italia? Fu una vera e propria guerra in cui, inequivocabilmente, si moriva per una bandiera e per un re: “sono un soldato di Francesco II” furono le ultime parole di Domenico Petrocelli di Moliterno prima di morire fucilato.
E le leggi erano quelle spietate e dure di ogni esercito e di ogni guerra: i nostri “briganti” mancavano certamente di mezzi e di coordinamento (al contrario di quanto più volte sostenuto dagli storici ufficiali) ma non erano secondi a nessuno nel coraggio e nella determinazione: il capo-brigante Coppa fece fucilare il fratello per un saccheggio non autorizzato in una masseria; Francesco Fasanella uccise un uomo che aveva tentato di violentare alcune ragazze; Domenico Di Sciascio, ex ufficiale borbonico, secondo una leggenda locale, fu catturato e ferito di sabato, giorno in cui andava disarmato perché dedicato alla Madonna; gli uomini della banda Masini affidarono ad un contadino di Caggiano 70 piastre per far celebrare messe alla Madonna di Viggiano; 15 briganti della banda Carbone preferirono morire bruciati piuttosto che arrendersi; molti altri come loro preferirono il suicidio all’arresto; a Monreale di Potenza Federico Aliano, prima di essere decapitato, “fuma e compie tutti gli atti religiosi con severità, chiede perdono ai presenti per i suoi misfatti e chiede ai genitori di badare all’educazione dei figli perché non accada a loro ciò che è accaduto a lui”.
Altro che delinquenti comuni… Luigi Alonzi detto Chiavone, in un suo proclama incitava i napoletani a combattere contro “il piemontese nemico del nostro re, della nostra monarchia, delle nostre leggi, del patrizio, del borghese, del cittadino, di tutti gli ordini militari, civili, religiosi il piemontese che arde città e massacra i fedeli a Dio… perché l’Arcangelo Gabriele ci covrirà con il suo scudo, la Vergine Immacolata con il suo manto e faranno vittoriosa la nostra bandiera che appenderemo in voto nel Tempio… e ritornerà quella gloriosa dinastia Borbonica che ci diede l’indipendenza dallo straniero”.
Altro che semplice ribellione contadina… Fu una guerra per la dignità e l’identità di un’intera nazione: si moltiplicavano in quegli anni e per tutti i paesi attraversati dai “briganti”, tra torce accese e campane a gloria, i simboli di questa dignità e di questa identità: teli bianchi per bandiere, quadri, immagini, statuette di Francesco e Maria Sofia, tarì borbonici bucati sui petti, “abitini” con monete di 5 grana: piccoli simboli di un’appartenenza spesso segreta ma fiera.
“Non sono briganti come gli dicono, non credete che vadano rubando davvero”, afferma Carlo Antonio Gastaldi, soldato di Biella passato al nemico, in una lettera al padre.
È una vera e propria guerra con un popolo intero che si ribella e scende a combattere anche senza armi per difendere Dio e Patria, Re e Famiglia, esattamente com’era avvenuto nel 1799, a Napoli come in Veneto, in Spagna come in Francia, con un patrimonio di tradizioni e di valori veramente italiano e veramente europeo che le culture ufficiali italiane ed europee hanno colpevolmente cancellato. E questo pesava, probabilmente, anche di più di motivazioni contingenti anche se importanti ogni tanto riconosciute storiograficamente (l’enorme carico fiscale, l’abolizione degli usi civici, la coscrizione obbligatoria).
È significativa la vicenda di uno dei tanti meridionali che presero le armi contro gli invasori: quella di Nunzio Tamburrini. Le foto che lo ritraggono in catene sulla porta del carcere di Civitavecchia sono tra le più utili che si possano ricordare: la fierezza e quasi il distacco che Tamburrini evidenzia nei confronti della guardia carceraria e dello stesso fotografo possono essere la sintesi della dignità di tutto un popolo disposto a combattere e a morire per la sua libertà. Tamburrini, capobanda di Roccaraso, fu arrestato nel gennaio del 1865 forse prima che, come tanti altri suoi compagni, si imbarcasse per le Americhe. Alcune fonti lo dichiarano fucilato a Teramo nel 1868 ma a noi piace ricordarlo, oltre che per il coraggio dimostrato durante i cinque anni della sua guerra, per un’ironia tutta meridionale che pure viene fuori da tutta la sua vicenda: dieci bottiglie di rum, una “pezzotta di formaggio di marzo” e “dieci pacchetti di cavurro” (sigari marca Cavour) chiede in un suo biglietto di ricatto il “feroce
brigante Tamburrini” famoso anche per i travestimenti da frate o da suonatore ambulante: una volta avrebbe addirittura avuto il coraggio di andare a vendere forbici e coltelli ad alcuni sottufficiali piemontesi.
“Ho trovato per tutto un affetto al principio monarchico che spinge al fanatismo, ma per mala ventura accompagnato da una paura che lo paralizza…- scrive Borjès nel suo diario – malgrado ciò ho compreso che se si potesse operare uno sbarco con duemila uomini… la dominazione piemontese sarebbe distrutta perché tutte le popolazioni si leverebbero in massa come un solo uomo. I ricchi, salvo poche eccezioni, sono cattivi dovunque e quindi assai detestati dalla massa generale…”.
Ma quei duemila uomini non arrivarono mai. Il regno fu perduto per sempre e vinsero quelli che l’eroico spagnolo poche ore prima di essere ucciso senza pietà e senza rispetto aveva definito “ricchi” e “cattivi”.
Prevalse un mondo nuovo che si portava via i re, i canti davanti ai fuochi e le bandiere, quelle facce scure e quegli occhi sorpresi o impauriti fissati per sempre da un lampo improvviso; si portò via i “Bellofatto”, i “Cinquecippone”, i “Nennanenna” e i “Crepasassi”, i “Pirichicchio” e i “Mussargiento”, con tutte le loro storie e tutti i loro stracci, tutti i sogni e le speranze che erano i sogni e le speranze di un popolo che fa ancora fatica, oggi, a sognare e a sperare.
Fummo cancellati dalla storia o diventammo dati sugli schedari della polizia (“occhi castagni, fronte regolare, carnagione regolare…”) o nomi e cognomi sulle liste delle navi che iniziarono a partire quando la guerra era già finita.
“Il popolo manca di lavoro, di pane, di speranza. Anche a Napoli si è avuto uno spettacolo pietoso –scrive Ulloa in una lettera del 1866- Arrivava una carovana ininterrotta di contadini delle Calabrie, della Basilicata e del Cilento che venivano per emigrare. Li hanno descritti pallidi, disfatti, con l’aspetto della più crudele miseria. Già una quantità di operai cacciati dagli arsenali e dai cantieri sono partiti per l’Egitto e dalla Sicilia a Tunisi, a Tripoli, ad Algeri. Molti cercano nel porto di Genova di imbarcarsi per l’America meridionale… Ma come è accaduto che gli abitanti delle Due Sicilie, il popolo meno fatto prima per lasciare la sua patria, se non per viaggiare, siano spinti ora da questa furia di emigrazione?”.
Tutti colpevoli e senza attenuanti i meridionali che scelsero il silenzio di fronte al massacro della loro gente: da Nitti a Villari, da Croce a Fortunato. Tutti colpevoli i tanti che non presero posizione o che preferirono rifugiarsi nei loro palazzi, sulle cattedre delle loro università o dietro le scrivanie dei loro giornali: come quel Melchiorre Delfico, disegnatore che invece di denunciare morti e devastazioni si divertiva e divertiva il resto dell’Italia disegnando caricature di “briganti meridionali infilzati a catena da un ferro piemontese…”.
Quei meridionali che una storia falsa e bugiarda ha definito “briganti” rappresentavano, nell’Italia di 150 anni fa, la società reale che si ribellava alle imposizioni di una minoranza che oggi definiremmo “società civile o legale”: noi che quotidianamente viviamo i problemi veri e concreti delle nostre città, assediati dai “finti rinascimenti” di ieri e di oggi, con la difficoltà di riconoscere nemici che non portano più divise piemontesi e lontani dai palazzi del potere e della cultura a pagamento, anche per questo ci sentiamo vicini ai nostri “briganti” e, forse, vorremmo somigliargli un poco. E ci possono servire come un esempio la dignità e la fierezza di quegli occhi che ancora intravediamo da quelle vecchie foto ingiallite tra le pagine della nostra memoria storica.
Gennaro De Crescenzo
Gaeta, 26 maggio 2001
Potrebbero interessarti anche: